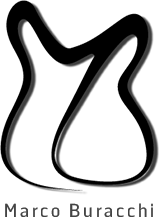Passo molto spesso ancora troppo tempo delle mie giornate, in modo non del tutto probabilmente maturo, nello studiare cose che non sono del tutto utili ad un mio scopo personale.
Per scopo personale intendo ovviamente il mio ultimo disco, che forse troppo si basa per certi aspetti, su di un versante “virtuoso” e meno melodico come la musica in realtà dovrebbe essere…avessi avuto genitori più severi…e fossi stato io forse un soggetto più talentuoso!
Ma lasciando da parte queste crisi esistenziali amici miei, passiamo ad argomenti più importanti; cose che in realtà in un primo momento potrebbero farvi pensare essere così distanti dal mondo chitarristico, ma che in realtà una volta lette e metabolizzate con calma e saggia passione dell’essere, ne potreste trovare usi e applicazioni continue ad alti livelli sonori.
IL NOME RIVOLTO DERIVA DAL FATTO CHE, RAPPRESENTANDO SCHEMATICAMENTE UN ACCORDO, IL SUONO PIU’ GRAVE VIENE RIVOLTATO:
sappiamo perfettamente che se abbiamo una condizione naturale di questa disposizione DO-MI-SOL
la terza diviene il basso (mi) Ergo il primo rivolto, quindi si chiama accordo di terza e sesta oppure, essendo il primo nella serie dei rivolti accordi di sesta! Se ora si rivolta anche il suono più grave di questo primo rivolto, il suono più grave di questo accordo sarà la quinta, e si avrà il secondo rivolto.
In altre parole: quando al basso vi è la 3° la triade è il primo rivolto e si indica col numero 6; quando al basso v’è la 5°, la triade è in secondo rivolto e si indica con 6/4.
Invito (e questo sono io Marco che dico questo, a leggere da pagina 68 in poi il manuale in 4° edizione come tratta il capitolo, per approfondire alcune tematiche relative ai concetti di base)
Sottolineo invece una questione:
L’inizio e la fine dovevano essere determinati, chiari, inequivocabili, e a questo scopo il rivolto, essendo una forma debole dell’accordo, era meno adatto della posizione fondamentale!!!
Vi sono nella letteratura musicale classica rari esempi di inizi volutamente vaghi nella tonalità (come la PRIMA SINFONIA DI BEETHOVEN) che comincia con un accordo di settima del I primo grado che porta alla sottodominante (NB IV), e solo nei nostri tempi essi hanno trovato un audace riscontro nel mantenere incerta anche la fine.
Sono sempre ora io (Marco) che mi permetto di esprimermi e sottolineare dei concetti che trovo più importanti di altri nel manuale:
non appena il basso (di una qualsiasi linea di portamento, e ovviamente stiamo sempre intendendo sulla chiave di lettura di una root, un primo rivolto, un secondo rivolto ecc. ecc..) non appena il basso dicevo, diventi più indipendente, formando ciò che chiamerei seconda voce principale, o seconda voce MELODIA, è obbligato a servirsi anche di altri suoni che non siano quelli fondamentali:
IN QUESTO CASO IL BASSO NON E’ PIU’ FONDAMENTO DELL’ARMONIA!!!!!!
Vi è chiaro quello che ho riportato?
ma tutt’al più fondamento dell’analisi armonica, che è una cosa ben diversa.
Supponiamo che al basso vi sia il Mi con sopra l’accordo si 3° e 6° do-sol-: in tal caso il mi del basso non ha nessun peso per il carattere della successione con l’accordo del seguente, me è il do la fondamentale…….
che determina la fora e il significato della successione armonica!
QUESTO E’ MOLTO IMPORTANTE AVERLO COMPRESO!!!!
Alla prossima
Tag
arnold schonberg
-
Compositore e didatta. Occupa un posto perminente nella cultura musicale degli inizi secolo, non solo perchè dal suo insegnamento usciranno due tra i maggiori musicisti della nostra epoca (Alban Berg,…